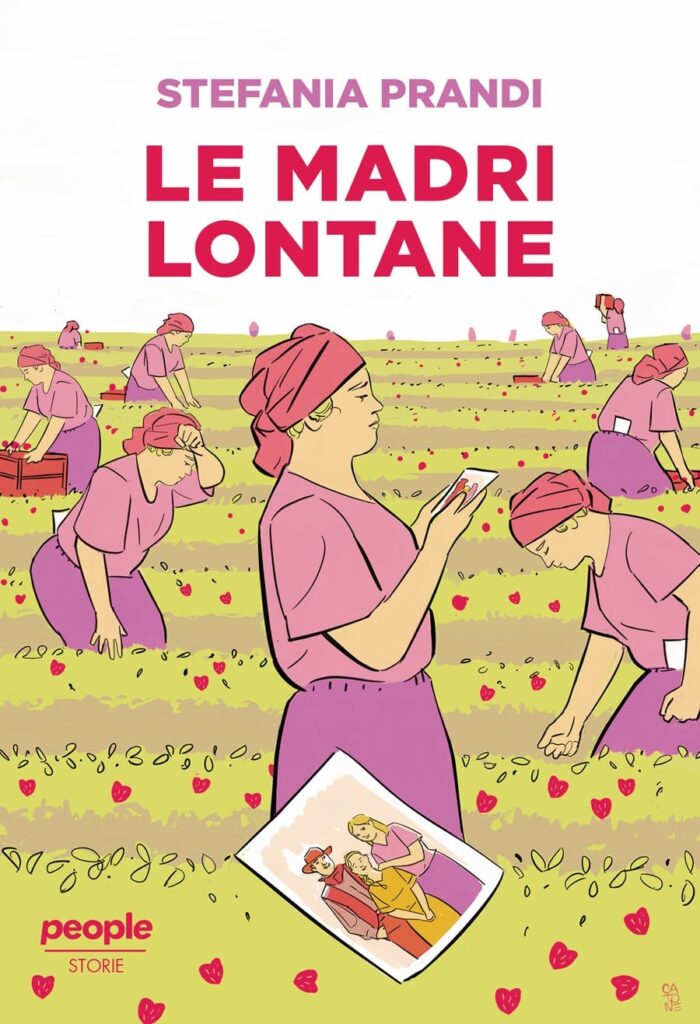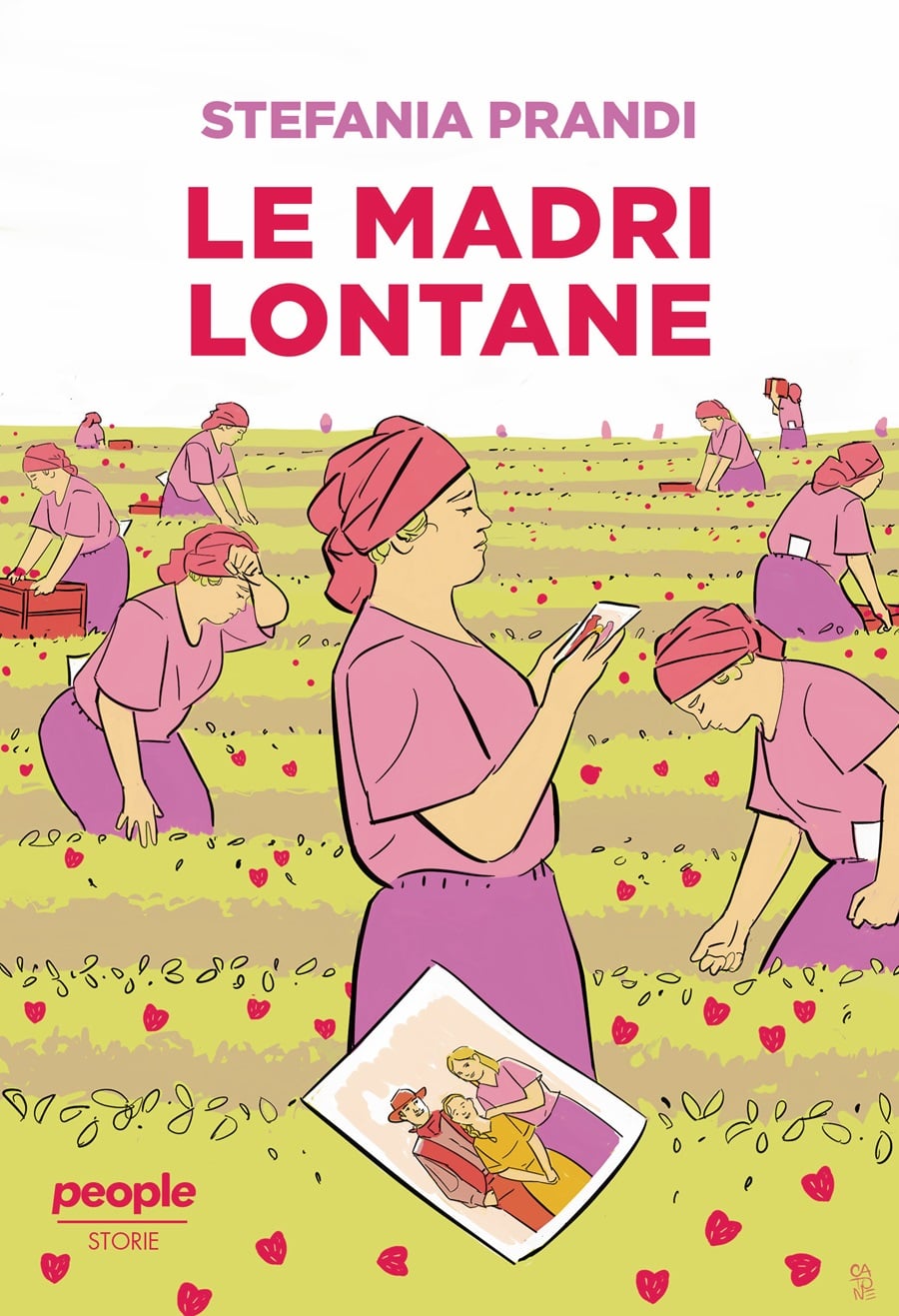
Lasciare i propri figli nei Paesi d’origine e vivere per anni nel dolore dell’assenza è il destino di molte braccianti rumene e bulgare impiegate, spesso in nero, nella raccolta della frutta e della verdura che arriva nei nostri supermercati. La stessa sofferenza vissuta da queste donne pesa sui loro figli, gli < orfani bianchi>, le migliaia di bambini che crescono lontani dalla propria madre, affidati alle cure di nonne o altri familiari.
Le madri lontane di Stefania Prandi (con la bella postfazione di Chiara Cretella che esplora anche le dinamiche madre-figlio da Melanie Klein a John Bowlby) edizioni People, è il racconto coraggioso delle conseguenze del caporalato e dello sfruttamento delle donne migranti nei campi italiani ed europei. Il reportage è stato realizzato con oltre settanta interviste a braccianti, psicologhe, storici, sindacalisti e insegnanti tra Romania, Bulgaria, Calabria. Basilicata e Puglia. Il materiale raccolto tra il 2021 e il 2023 è stato accuratamente vagliato e selezionato.
Un lavoro accurato che attraversa le vite di queste donne, di queste madri, tra paghe da fame, caporalato, lavori in nero, molestie e ricatti sessuali, malanni fisici anche gravi e dolori della mente. Sole con il loro dolore, si scambiano le storie e poi in una maschera di indifferenza tornano alla loro occupazione nelle serre. Si parla di agricoltura ma anche di lavoro di cura come badanti.
Il fenomeno secondo Save the Children Romania
Secondo una ricerca recente di Save the Children Romania, oltre mezzo milione di minori rumeni (cinquecentotrentaseimila, per la precisione, circa il quattordici per cento del totale) aveva, nel 2022, almeno un genitore all’estero. Dei bambini conteggiati dall’organizzazione non governativa, centottantaquattromila sono rimasti del tutto senza cure parentali dirette, con entrambi i genitori espatriati. I Senza madre erano centocinquantacinquemila. L’Italia (ventuno per cento), la Spagna (diciassette per cento) e l’Austria (dodici per cento) sono le prime tre destinazioni per la migrazione femminile. Il venti per cento delle donne migranti è occupato nel settore agricolo.
Storie di schiavitù a due passi da noi, storie che non vogliamo vedere veramente nella loro complessità. Che invece ci riguardano da vicino.
Sofferenza
Il senso di colpa delle madri migranti è un buco nero nel quale finiscono le notti insonni, l’abulia, la stanchezza cronica e l’alcol. Clea segue la regola di bere soltanto in compagnia. Sorseggia piano il vino che le verso. Ha visto troppe donne, nel corso degli anni, finire nella spirale dell’alcolismo. Allora meglio tenersi occupate. <Per non pensare> mi dice. Clea oltre a fare la bracciante, pulisce le case e rammenda vestiti su richiesta.
<La mia vita è così, costellata dalle difficoltà. Non sono l’unica, anche le altre rumene e bulgare hanno un’esistenza faticosa. Sul lavoro ci umiliano, ci urlano dietro, ci ricattano, cercano di piegarci, ci fanno sentire degli scarti perché siamo straniere. Ma non riusciranno mai a mettermi sotto, io reagisco.
L’autrice
Da sette anni mi occupo delle condizioni delle braccianti. Un sentimento di ingiustizia mi pervade ogni volta che concludo un’intervista nonostante <ci siano i padroni buoni> È il sistema a sconcertarmi. Per comprare il cibo che mettiamo in tavola, attingiamo a manodopera a basso costo, disposta a tutto per sopravvivere e assicurare un futuro migliore ai propri figli, fornita da interi Paesi ai margini dell’Unione europea.
I nonni
I bambini vengono affidati alle nonne perché è difficile portarli con sé quando si va a fare le braccianti. I lunghi orari della campagna, con le levatacce quotidiane, le abitazioni anguste, spesso non a norma, e la stanchezza cronica, mal si conciliano con le cure per l’infanzia. Ed è impensabile trasferirsi con la famiglia per l’altro lavoro – cucito su misura dagli italiani sulle donne comunitarie – il “badantaggio”, per il quale serve un impegno di mesi, se non di anni.
Sindrome Italia
Nechita conosce bene la <sindrome Italia>, ossia la condizione di estremo disagio dovuta all’aver delegato la maternità ad altri. Coniata inizialmente da due psicologi ucraini nel 2005, riguarda anche le braccianti. <In generale le donne soffrono di insonnia, disturbi d’ansia e stress da isolamento. A causa dello scarso livello di istruzione, partono prima ancora di apprendere la lingua e, giunte sul posto, faticano a creare dei legami. L’agricoltura è meno traumatica del badantaggio, che può implicare anche quindici o venti anni di assenza. Chi lavora nei campi, in genere, fa avanti e indietro, va via per alcuni mesi e poi riesce a rientrare a casa.>
Ogni anno, circa il cinque per cento delle ospiti dell’ospedale psichiatrico di laşi è rappresentato da donne con la <sindrome Italia>. Arrivano in ambulanza oppure portate dalle famiglie e vengono ricoverate d’urgenza. Può succedere che qualcuna si presenti spontaneamente, in preda a un forte malessere. In certi casi gli assistenti sociali dei comuni in provincia di Iaşi contattano Nechita e insieme, in accordo con i rappresentanti delle istituzioni locali, come i sindaci, scelgono l’opzione migliore per accogliere la lavoratrice nella struttura.
Anni fa, Nechita ha seguito una famiglia in cui erano partiti prima la madre e poi il padre. Il bambino, rimasto con i nonni, ha iniziato a manifestare segni di malessere. Nello stesso periodo, la madre è entrata in depressione ed è stata ricoverata nella struttura. Crescendo, il figlio ha sviluppato una sindrome maniaco-depressiva. Ora tutti e tre sono in Germania. Il ragazzo non è mai riuscito a completare gli studi universitari ed è stato curato in un ospedale psichiatrico tedesco per gli episodi maniacali. Nechita è ancora in contatto con il medico che lo segue.
Il distacco dalle madri è nocivo: alcuni bambini si portano dietro i traumi per tutta la vita. Non necessariamente sviluppano o manifestano disturbi psichiatrici, ma l’esperienza li segna per sempre, influenzando i loro rapporti personali.
Gli orfani bianchi
I minori, affidati ai nonni o ad altri parenti mentre i genitori espatriano, vengono chiamati orfani bianchi. Oppure, con una definizione inglese usata dall’organizzazione internazionale Unicef (l’Agenzia delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dei bambini e delle bambine), <left behind>, abbandonati o dimenticati. Come spiega Anca Stamin, project manager di Save the Children Romania, l’assenza delle madri è avvertita più intensamente perché sulle loro spalle c’è il carico tradizionale delle faccende domestiche e della cura dei figli.
Se le genitrici si assentano per lunghi periodi, nei più piccoli affiorano sentimenti di abbandono, calo di fiducia in se stessi e sensi di colpa. E i bambini vengono investiti dall’idea che l’emigrazione materna sia in funzione del loro bene. In media, le mamme partono per la prima volta quando i bambini hanno sei anni. Poco più della metà torna a casa una volta all’anno, mentre il sette per cento ogni due anni ancora meno.
E aumenta il rischio di abbandono scolastico.
Le lettere degli orfani bianchi
“Ogni lettera termina con TI VOGLIO BENE, MAMMA.” La voce di Rosita Alexandrova, maestra di sessantaquattro anni, si spezza. Le labbra hanno un fremito e non riesce a trattenere le lacrime, mentre racconta di quando aiuta i suoi alunni a scrivere alle madri lontane. Alcune non tornano nemmeno per Natale, e allora i messaggi dei figli diventano più accorati.
La violenza domestica invisibile
Come ha scritto Elena Stancu sul giornale romeno Libertatea, in un reportage pubblicato a luglio 2022 (finalista nel 2023 allo European Press Prize), uno dei motivi meno indagati per cui le donne rumene emigrano è la violenza domestica. Secondo quanto riporta Stancu, nel 2020 sono stati segnalati ventiseimilaottocentonove casi di violenza domestica e settantadue persone sono state uccise, la maggior parte delle quali donne e bambini.
Per inquadrare il contesto, chiarisce Stefano Bottoni, il già citato studioso di Storia dell’Europa orientale, si deve ricordare che la Romania è ancora uno dei Paesi europei con la maggiore percentuale di popolazione che lavora nelle campagne, circa il quaranta per cento del totale. Un’agricoltura di sussistenza, si vive col poco che si coltiva.
I modelli familiari sono arretrati, patriarcali, imperniati sullo strapotere del padre padrone. In Romania il divario sociale è tuttora enorme: i grandi centri logistici e universitari ultramoderni, realizzati negli ultimi vent’anni, non riescono a colmare la povertà di ampie aree periferiche, ferme ai primi anni della seconda metà del Novecento, nelle quali anche avere il bagno in casa è un miraggio. Uno sviluppo diseguale, favorevole per le famiglie benestanti e svantaggioso per i ceti meno abbienti.
L’emigrazione
Secondo un recente rapporto della Banca Mondiale, la Romania ha registrato il più alto tasso d’emigrazione tra i membri dell’Unione europea dal 1990. Tra i tre e i cinque milioni di rumeni- su una Nazione di quasi venti milioni di abitanti – vivono e lavorano all’estero. La maggior parte di loro è in età lavorativa e rappresenta quasi un quinto della forza lavoro del Paese.
Lo stesso spopolamento accade in Bulgaria.
Ma non tutte lasciano i figli in patria, con conseguente grande fatica e problemi quotidiani di conciliazione.
Le violenze
Non esiste una mappatura con i numeri reali delle violenze sessuali, dei ricatti, degli abusi e degli stupri nei campi italiani. Non ci sono nemmeno statistiche a disposizione. Di certo c’è che i molestatori possono sottrarre i documenti e minacciare i familiari, inclusi i figli in Romania e in Bulgaria.
Fragole e pomodori che arrivano sulle nostre tavole portano con sé tutte queste storie e dolori, in cui traspare tutta la forza e il coraggio delle donne. Stefania Prandi entra con delicatezza estrema in queste esistenze, mostrandoci uno spaccato che non lascia spazio a edulcorazioni o minimizzazioni. Donne vere nelle loro vicende non estetizzate, come spesso accade quando ci si accosta a certe narrazioni. Abbiamo bisogno di questi reportage, di conoscere da vicino le realtà dell’agricoltura nostrana, della cura, di quanto i diritti vengano sempre più spesso calpestati e di cui ci accorgiamo solo quando arriva un caso in cronaca nera. L’autrice riesce a percorrere strade poco battute dai media, per donarci degli scorci di vita di cui dobbiamo occuparci e che non ci devono far voltare dall’altra parte. In queste storie ci sono anche le tracce di tutte le donne che lavorano lontano da casa e che purtroppo vivono gli stessi sentimenti di queste madri. Sono storie che ci riguardano, da molto vicino.